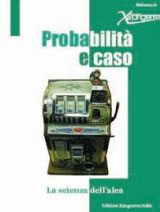
PROBABILITA’ E CASO – EDIZIONI KANGOUROU ITALIA 2011
( www.kangourou.it ).
Il libro è una collezione di articoli che offre una panoramica sull’utilizzo della teoria della probabilità, e del caso,
negli ambiti più disparati delle attività umane.
Uno di questi articoli tratta del ruolo del caso nell’espressione artistica, pittorica in particolare.
Viene citato Paolo Bonaldi.

FRATTALI – EDIZIONI KANGOUROU ITALIA 2010 ( www.kangourou.it ).
Il libro è una collezione di articoli che offre una panoramica della geometria frattale nei suoi multiformi aspetti.
Uno di questi articoli tratta il tema della misura frattale dell’Arte.
Un’opera di Bonaldi, sottoposta a specifico software, mostra un carattere frattale.
Priscilla (2005)
Patrizia Serra (2005)
La densità delle cose (2005)
Marco Magrini (2005)
Pensiero inquieto (2004)
Una voglia indomabile alla ricerca di luci e di colori. Un viaggio migrante verso l’oltre e l’altrove, che vaga nella galassia, attraversa nebulose e sfiora fasci di stelle. Sperdute nelle galassie misteriose dipinte da Paolo Bonaldi, vagano “fluorescenze” e le tracce delle “sirene”. È notte nell’universo. Sembra una notte colma di dolcezza avvolta in musicali silenzi, ma dal cosmo oscuro un’avanguardia di “fluorescenze” avanza in gran velocità. Non ho bisogno di chiudere gli occhi per poter immaginare, c’è tutto lì, sui rotoli blu – le opere recenti di Paolo Bonaldi. E il momento del blu, il colore che acquista un autoritario ruolo da protagonista, si muove e si propone alla valutazione di chi osserva con una perentorietà che deriva forse dalla consapevolezza dei risultati raggiunti dall’artista. Guardo i rotoli blu, eppure, nel fondo si inseguono le macchie di mille cromie: sono raggi delle stelle, della luna che si incrociano, che si scontrano con le “fluorescenze” per avviarsi alle esplosioni ormai vicine. Mondi lontani vanno in frantumi, non si può più tornare indietro. Con gli occhi faccio scivolare le immagini su e giù, cerco di seguire il movimento delle “fluorescenze” – ma l’operazione risulta molto difficile per la gran velocità. Io non mi arrendo, continuo con lo sguardo a corrergli dietro, perchè solo così si entra nel respiro dell’universo che assorbe, gusta e rigetta. È notte nell’universo. Dentro di me sono già partita, sto precipitando nello spazio e nel tempo, la pelle sfiorata dalle “fluorescenze”, mi sento i capelli in fiamme, sento pianeti girare sempre più veloci. Mi lasci affondare nel blu, rabbrividendo un poco. E adesso? Ma non posso permettermi il lusso di riflettere. Ho appena il tempo di guardare da vicino, di godermi questa straordinaria sensazione di piacere. Intorno un silenzio più profondo di quanto abbia mai udito, perfino i pianeti e le “fluorescenze” bloccati nell’immobilità. È notte nell’universo. Buio, luce e colore.
Beata (2004)
Flowers (2002)
Storia naturale. Piante carnivore e fiori artiglianti. Infiorescenze anomale, che affondano petali e corolle taglienti in uno spazio allusivo e totalizzante. Forme acute e acuminate, schiuse a poco a poco, come per gemmazione spontanea, da spore di ferro o di rame implose su se stesse quasi per un implicito atto di auto-protezione, necessario nella fase più delicata dello sviluppo biologico e spaziale. Paolo Bonaldi ha attinto le forme del suo regno pseudo-vegetale da un erbario fantastico e pieno d’ambiguità, elaborato in almeno tre anni di studi “naturalistici” (prima realizzava strutture metalliche dalla forma più o meno sferica e dal forte, intrinseco dinamismo, in cui vanno, peraltro, senz’altro riconosciuti i precedenti diretti di queste realizzazioni ultime) che, fuor di metafora, consistono nella scoperta di un personale universo poetico e formale e quindi, inevitabilmente, nell’approfondimento sempre più tenace e coraggioso delle proprie ragioni interne. Per il giovane artista lombardo, la progressiva messa a punto di queste originali forme plastiche e pittoriche ha assunto l’andamento di un processo biologico, quasi si trattasse dell’evoluzione spontanea di una nuova classe di organismi certamente dotati di autonomia e quasi di una creatività propria; creatività genetica, naturale. Ed è così, infatti, che l’artista ne parla: il suo corpo, il suo sguardo, i suoi gesti, si lasciano avvolgere, conquistare e persino ferire dai segni e dagli aculei di metallo che prendono lentamente consistenza fra le sue mani, quasi le mani e il corpo fossero semplicemente strumenti passivi, puramente agiti e manovrati dalla forza intrinseca di questi oggetti spaziali. In un giovane provvisto di un eccellente bagaglio di cultura e consapevolezza del proprio tempo e delle strade, anche le più contraddittorie e divergenti, della storia dell’arte, è raro ritrovare una coincidenza tanto immediata ed efficace di pulsione ed esigenza formale. Per Paolo Bonaldi la natura del sentire coincide con la natura tout court. La cultura con la coltura di organismi non soltanto, non semplicemente amichevoli o docili. Il processo creativo assomiglia all’evoluzione della specie. Ma anche all’esuberanza della polluzione spontanea di semi e di corpi su un humus adeguato. Avanguardie e altre divagazioni. Con tutto questo, non ci troviamo affatto di fronte ad un fenomeno, o meglio una scelta, per così dire, ingenua. Nella spazialità sovraccarica e leggerissima che Bonaldi predilige, i ricordi e i collegamenti si affollano e si intrecciano l’uno con l’altro in una sintesi assolutamente personale. Balla, per esempio (soprattutto quello dei Vortici e delle Linee di velocità). “Bisogna rendere l’invisibile che si agita e che vive al di là degli spessori, ciò che abbiamo a destra, a sinistra e dietro di noi, e non il piccolo quadrato di vita artificialmente chiuso come fra gli scenari di un teatro… abbiamo dichiarato che bisogna dare la sensazione dinamica, cioè il ritmo particolare di ogni oggetto, la sua tendenza, il suo movimento, o per dir meglio la sua forza interna… Ogni oggetto rivela, per mezzo delle sue linee, come si scomporrebbe secondo le tendenze delle sue forze”. Esigenze come queste, pubblicate nel catalogo della Prima Esposizione di Pittura Futurista (1913), non hanno perduto la loro attualità per Bonaldi, anche se la finestra prospettica del naturalismo ottocentesco e di tutta la tradizione pittorica dal Rinascimento in poi, non è certo più un termine di confronto e di scontro oggi, a secolo ormai concluso, e sono ben altre le frontiere possibili verso cui si protende il fare creativo di un artista ambizioso. Lo spazio, per esempio, il suo spazio, è già spazio liberato, conquistato, mobile, aereo, avvolgente. Bonaldi agisce secondo proiezioni di efflorescenze segniche e cromatiche improvvisamente distese ed allungate lungo tensioni imperscrutabili, che si materializzano oltre il foglio, in una succesione, una continuità di superfici leggerissime collegate insieme; oppure che si proiettano decisamente nella terza dimensione, talvolta con l’ausilio di supporti trasparenti ma carnosi di resine colorate e addensate come liquidi organici. Ma si tratta ancora, anzi più che mai, di “forza interna” di “ritmo particolare di ogni oggetto” che in questo caso, è ritmo di crescita organica, ritmo barocco, in altre parole, ritmo aggressivo che, giusto in virtù della propria aggressività, sfugge a qualsiasi sospetto di decorativismo e di leziosità. Informale, allora, ecco un altro riferimento indispensabile per parlare di questo lavoro, informale di segno e di gesto, ma calibrato da un autocontrollo volto sempre a garantire la prevalenza della forma, di un oggetto grafico o plastico che non rappresenta soltanto la pulsione, il desiderio, l’angoscia, in una parola, lo stato interiore, ma soprattutto vive di se stesso, della propria elegante, pericolosa, metamorfica energia interna. Arte totale, spazio totale, ambiente; senza preoccuparsi di concepire l’opera come installazione, sfuggendo così quasi ad un diktat del nostro tempo e della nostra cultura, Bonaldi riesce a costruire con rotoli di carte una spazialità avvolgente, in cui il fruitore si trova suo malgrado completamente immerso e perduto fra forme promettenti ed ostili, che lo coinvolgono nella propria liberissima fluttuazione, in un continuo aprirsi, reale o puramente evocato, al di là della superficie su cui sono tracciati i segni, gli strappi, le tracce di questa materia. Un risultato che non si esita a definire straordinario, soprattutto se si pensa ai mezzi tradizionalissimi con cui l’artista lo ottiene, refrattari a qualunque sussidio tecnologico, ai video, alle proiezioni, alle strumentazioni digitali senza le quali, oggi, sembra diventato tutto impossibile, tutto obsoleto, tutto limitato. Toccare. Invece no. Bonaldi si avvale ancora dell’antica arte della manipolazione, del contatto con i materiali; ama sperimantare, sulla propria pelle (organo dimenticatissimo dalle nuove tecnologie) sempre nuove sensazioni, ha bisogno di toccare cose differenti, non esclude a priori nessun elemento, nessuna materia purchè riesca a metterle le mani addosso, a scalfirla e a scalfirsene in una presa davvero diretta, senza riserve, senza cautele. È un pittore, è un disegnatore, finchè la pittura, il disegno, i colori gli consentono di far crescere la sua flora mutante in spazi sufficientemente rarefatti, sospesi, come una coltura nel vuoto, quel vuoto primigenio da cui tutto ha origine. È scultore, anche, ogni qualvolta senta l’esigenza di costruirle per davvero (e per una specie di insorgenza di “realismo” però non letterale, non didascalico, non rappresentativo ma costruttivo) le sue efflorescenze affilate, gangli di forme organiche strette intorno ad un nucleo di vuoto dinamico, contenitori di spazio attivo, in divenire; oppure protese dappertutto, oppure incastonate su radici di resina e di plexiglas. Forme che sembrano nascere dal suolo o dalla parete magari, come orchidee parassite, ma sembrano comunque nascere grazie ad un processo di generazione spontanea che nell’arte delle ultime generazioni trova davvero pochi, pochissimi paralleli. Interno /esterno. I segni di Paolo Bonaldi sono concepiti velocemente, come atto unico, irripetibile. Non ammettono correzioni, ripensamenti. Eppure sono lenti, meditabondi e quasi “orientali” nell’integrarsi allo spazio. A modo loro, contengono la suprema lezione dei Concetti spaziali di Lucio Fontana: vivono, cioè, di una sospensione in cui si perdono tutte le distensioni troppo nitide, le separazioni troppo perentorie e dove l’interno si fa continuamente esterno sia in senso spaziale che emozionale. L’interno, il vuoto, genera ed è generato fino al limite provvisorio che il segno offre, di volta in volta. Questo segno allora, questo segno refrattario alle classificazioni, che sa essere grafico nello spazio e plastico sulla superficie, può essere letto anche come modo della relazione fra l’interno e l’esterno, fra un mondo interiore sicuramente turbolento ed una messa in forma complessa ed esigente, meditata, sistematica; lontanissima, in altre parole, da quegli additivi chimici, tecnici e spirituali cui le neoavanguardie degli anni Cinquanta facevano sistematicamente ricorso per prevenire l’insorgere di una razionalità troppo prepotente e troppo limitativa. Per Bonaldi invece, e per la sua generazione cresciuta sotto il segno della disillusione rispetto a qualsiasi ideale romantico di soggettività, e di un’incalzante minaccia di de-soggettivizzazione, il semplice abbandono all’inconscio o a qualsivoglia automatismo non è più, certo, una soluzione praticabile. Anzi, ogni risorsa ormai, ogni capacità va messa e frutto per permettere la formazione di qualcosa che possieda ancora il valore della soggettività e la forza del progetto; qualcosa, in altre parole, che sia all’altezza di misurarsi con questa epoca di metamorfosi da cui nessun ideale, nessun linguaggio e nessun organismo può considerarsi indenne. Ed è proprio in considerazione delle inquietudini prodotte dal contesto in cui viviamo, che acquista ancora maggiore interesse la minacciosa innaturalità della natura naturans pazientemente articolata da Paolo Bonaldi: le sue forme aliene nell’impatto ma tradizionali nella tecnica, eleganti ed invasive, impregnate di memoria ma pienamente originali.
Martina Corgnati (2002)
Vuoti che riempiono (1998)
Elisabetta Longari (1999)